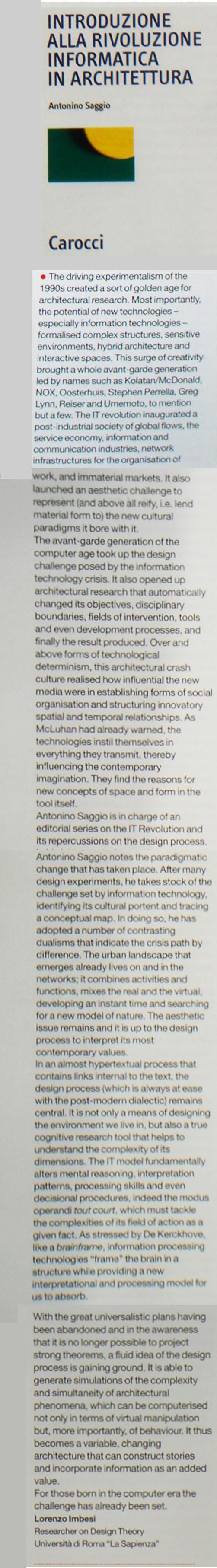Antonino Saggio I Quaderni
Recensioni

go to blog for further comments
on this book >>
Estetiche di rottura recensione di Lorenzo Imbesi Pubblicata su "Domus" dicembre 2007
Ogni nuova tecnologia che si fa strada, nel momento in cui emerge, si presenta sempre come una natura artificiale esterna con la quale imparare ad interfacciarsi. Ma per le generazioni successive, quelle che crescono in un ambiente che ha già acquisito la stessa tecnologia, diventa un fenomeno culturale percepito come fatto naturale, che sviluppa conseguentemente nuovi modelli e strutture mentali.
Lorenzo Imbesi
Recensione di Antonello Marotta Pubblicata su "industria delle Costruzioni" luglio 2007 Come
si può definire il paradigma dell’informazione, quali rapporti intercorrono tra
informazione e nuova visione del tempo, come le nuove tecnologie hanno
modificato la stessa nozione di spazio.
Antonino Saggio da risposta a questi temi nel nuovo libro Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura, edito da Carocci editore. L’autore dopo aver
attraversato la modernità nei testi dedicati all’opera di Pagano e di Terragni
e averci mostrato le trasformazioni che a partire dagli anni Settanta, nella
produzione di Eisenman e di Gehry, hanno determinato nuovi percorsi compositivi
e spaziali, ci offre con questo nuovo lavoro una mappa teorica e concettuale
della ricerca generata dalla rivoluzione informatica. Il volume affronta per la
prima volta una trattazione complessiva, sia sul piano teorico che operativo,
con l’intento di evidenziare nuovi processi ideativi e strutturali
dell’architettura digitale.
Il testo è pregevole in
quanto sintetizza almeno 10 anni di ricerche condotte in parallelo con la
collana da lui diretta La rivoluzione informatica in architettura, pubblicata per diversi anni all’interno della Universale
di Architettura di Bruno Zevi, che è
stata tradotta in inglese, cinese e coreano, ed oggi edita con grande cura
dalla Edilstampa.
Vediamo in sintesi i
passaggi significativi del testo.
Innanzitutto Saggio concepisce e struttura il libro come una postazione interattiva, in accordo con i temi di cui tratta, in cui come in un sistema museale è possibile muoversi attraverso una lettura sequenziale o di tipo ipertestuale. I temi sul tappeto riguardano la Città, il Paesaggio, l’Informazione, il Tempo, lo Spazio, il Modello. L’aspetto centrale è che queste categorie (che sono quelle classiche disciplinari) vengono rilette alla luce della rivoluzione informatica, delle informazioni che oggi viaggiano a distanza, costruendo network e programmi integrati che uniscono, all’interno di un modello complesso, aspetti strutturali, di costo e beneficio, di fisica tecnica. La tesi che alimenta il libro è che l’informazione (in formazione, ovvero come fa notare l’autore, in costante, dinamico, inesausto, muoversi e divenire), intesa come una massa fluida che deve prendere forma, sia la nuova materia prima dell’architettura contemporanea. Saggio offre al lettore un nuovo modo di intendere il progetto, la città, il paesaggio. Si comprende dalla lettura, direzionata agli studenti, ma che diventa uno strumento utilissimo per ricercatori e studiosi, che lo sfondo che struttura il pensiero vive di ambienti da sempre fertili: il mondo dell’arte, della letteratura, del cinema. Il testo costruisce nuovi meccanismi relazionali a favore di una lettura della rivoluzione informatica che è al contempo l’intreccio di aspetti estetici, tecnologici, artistici e sociali. L’autore invita il lettore a concentrarsi su un nuovo paesaggio mentale, metaforico, ricco, allusivo. Si percepisce che il libro si muova su due binari distinti che si intrecciano costantemente lungo l’esposizione: un piano effettuale, dato dalla analisi dei sistemi che governano il progetto sempre più interattivi, dinamici, pluristratificati ed un secondo livello che costituisce lo sfondo di uno scenario a venire, che diventa per l’autore il piano di ciò che l’interattività potrà offrire in futuro: un’architettura che grazie alla tecnologia possa diventare uno strumento sociale di rinnovamento. Il libro come detto vive di
queste linee che si intrecciano, come nei diagrammi di Paul Klee. Queste
piattaforme concettuali e mentali si rinseguono lungo il testo, pensate come un
meccanismo di rimandi. Da qualsiasi punto uno si trovi il testo gioca con il
lettore, rinviandolo ad altri passaggi, a testimoniare che i temi affrontati
siano fonte di un unico pattern relazionale.
Il tempo come si evince
dalla lettura del libro e dalla stessa struttura narrattiva e concettuale (che
viaggia per salti o in continuità) diventa il principio cardine che anima il
libro, ma più profondamente ci aiuta a comprendere la stessa visione di spazio
contemporaneo. La rivoluzione informatica, intesa come infinita processualità,
scardina i principi del tempo stabile e a-priori.
L’autore ci invita ad entrare in una nuova visione spazio-temporale, in cui l’architettura entra nella sfera delle infinite possibilità di prendere forma, di cristallizzarsi in uno dei suoi innumerevoli potenziali. Ma questo passaggio, offerto dagli strumenti, entra in una sfera più complessa. Recuperando il famoso artificio elaborato nel 1884 dallo scrittore Edwin A. Abott nel romanzo Flatland, unitamente agli studi elaborati nell’Ottocento dal matematico George Riemann che ha introdotto l’idea dello spazio quadridimensionale e gli studi sulla topologia, oggi centrali per la comprensione del cyberspazio, Antonino Saggio intreccia il pensiero scientifico con quello letterario per introdurre il tema del salto, concettuale, processuale e compositivo che permette di spiegare la nuova visione del tempo e dello spazio dell’architettura informatica. «Qual è la navigabilità prevalente di uno spazio a quattro dimensioni? In quella lineare la navigabilità è solo quella del binario, in quella a due è evidentemente piatta, in quella a tre è anche verticale, ma la navigabilità del mondo a quattro dimensioni è esattamente quella del salto! Se in un mondo a due dimensioni posso cambiare continuamente linea e in quello a tre posso cambiare continuamente piano, in quello a quattro posso cambiare continuamente volume, posso cambiare sistema di riferimento tridimensionale. La navigabilità di base di un mondo a quattro dimensioni è quella che permette di saltare da un mondo a tre dimensioni a un altro a tre, e questo salto non è solo spaziale, è spazio-temporale». Ad Antonino Saggio, una
nuova generazione critica, di cui faccio parte, è debitrice non solo dei temi
affrontati nelle due collane che da anni cura con grande competenza, ovvero la
già citata Rivoluzione informatica e la serie Gli architetti, che
Bruno Zevi aveva promosso a partire dal 1978, ma anche di una nuova modalità
operativa Il per approfondire, o Bibliografia
ragionata che, a differenza dei
classici apparati di note, che in maniera lineare rinviano al testo citato,
permettono all’autore di allargare il campo, mostrando una serie di livelli che
altrimenti non verrebbero evidenziati.
Sembra un passaggio
secondario ma questa piattaforma consente di offrire al lettore attento o al
ricercatore strumenti per allargare il campo e permettono all’autore di
inserire una serie di strati che in un testo canonico verrebbero esclusi. In
questo volume la bibliografia ragionata diventa un vero e proprio libro nel
libro.
Con la Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura Antonino Saggio sgombera il campo da facili semplificazioni, quelle che definiscono le due retoriche che aggravano la critica odierna, ovvero la retorica della perdita e, per riflessione, la retorica del nuovo; la prima considera il tempo passato come eroico, su uno sfondo ideologico appesantito dal disagio per la perdita della condizione etica del progetto, la seconda considera ogni innovazione tecnologica come portatrice di grandi conquiste. L’autore invita a leggere questa trasformazione tecnologica attraverso la lente di osservazione del mondo dell’arte e di quello scientifico sullo sfondo di nuove protesi sempre più complesse. Il volume, in ultima analisi, offre una nuova prospettiva di rilettura del mondo sedimentato: quello antico e quello multimediale offerto dall’Information Technolgy, invitandoci a percepire nuovi legami sintattici. Nel 1969 Fernand Braudel in Scritti sulla storia analizzava i
tempi storici in sequenze di lungo, medio e breve periodo, ovvero i grandi
cicli di pensiero durati secoli, quello platonico – aristotelico, sino
all’avvenimento, la cronaca giornaliera. Utilizzava per far comprendere questi
sistemi la metafora del mare, i grandi fondali, visualizzanti i cicli lunghi,
sino alla spuma delle onde che rappresentava l’avvenimento quotidiano. Ciò che
lega questi diversi tempi è la stessa sostanza del mare. Di conseguenza il
tempo non può essere isolato o congelato in categorie dialettiche, in quanto
facenti parte di un’unica sostanza. La sostanza, che per Edoardo Persico è
desiderio di una speranza etica e sociale, diventa nel pensiero di Antonino
Saggio il legame che unisce la contemporaneità agli strumenti del mito.
Antonello Marotta
Recensione di Antonino Di Raimo pubblicata in "Metamorfosi" n. 66, 2007
E’ da poco uscito il volume “Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura”, edito da Carocci, e scritto da Antonino Saggio, docente di Progettazione Architettonica nella Facoltà L. Quaroni, dell’Università La Sapienza. Questo libro, per certi versi molto atteso, cerca di dare conto, sul piano teorico, ma non senza tracciare delle possibili direzioni operative, della centralità nella cultura contemporanea, del nesso fra paradigma informatico e architettura. Tale rapporto tutt’altro che scontato, o dato per acquisito, è indagato attraverso un approccio si direbbe globalmente cognitivista, ma profondamente teso ad interrogarsi circa la possibilità di definizione di un nuovo sentire, una nuova dimensione estetica, innescata appunto dalla Rivoluzione Informatica, dizione che costituisce anche il nome della collana diretta dall’autore del libro.Infatti, sebbene la parola rivoluzione evochi immediatamente l’immagine di un cambiamento politico epocale, un rovesciamento in accelerazione di fatti e di cose, la rivoluzione al centro di questo libro, che è per l’appunto quella Informatica in Architettura, sembra essere, a nostro avviso, di ben “altra sostanza”, che quella dei mutamenti, violenti e sofferti. Rivoluzione infatti, nella sua accezione fisica, anziché politica, è moto armonico di corpi celesti nello spazio, attorno ad altri corpi. Dunque, la rivoluzione innescata dal paradigma informatico
sembrerebbe avere questo carattere di movimento armonico, ciclico e non
violento per definizione, la cui portata in architettura, chiedeva urgentemente
una trattazione teorica pertinente. Se infatti, potrebbe apparire ormai
scontata, la presenza dello strumento basato sull’elettronica nella pratica
progettuale, meno scontata e assolutamente necessaria, è questa interrogazione
dell’informatica tutta orientata -per dirla con Kuhn – alla scoperta delle
“promesse del paradigma” nel fare architettura.
Del resto uno sguardo ai temi indagati
nella prima parte, ovvero “comunicazione”, “città” e “paesaggio”, rivela che questi
siano concatenati logicamente, non tanto nei salti di scala che naturalmente vedrebbero
in rapporto città e paesaggio, quanto nei salti consentiti dalle logiche
tipiche del paradigma informatico, che ne modella la fisionomia in quanto
scenari centrali dell’agire architettonico contemporaneo, connessi
continuamente l’uno con l’altro.In tal senso, la presenza massiccia dei media nella società
contemporanea, che pure sul paradigma informatico via via si ridefiniscono,
richiede un confronto continuo, con la questione “comunicazione” in
architettura, sicuramente come ci dice l’autore, più a livello cognitivo che
narrativo; analogamente la “città” che ci si invita a guardare più attraverso
le logiche del display che quello dell’orologio, diventa più digitale, un
apparato soggetto a dei refresh continui, più che alle logiche del meccanismo;
così infine “il paesaggio”, tema che Saggio impernia, oltre che sulle urgenti
necessità ecologiche, sulle quali gran parte della ricerca è impegnata, sulla
proprietà di costituire in primis rappresentazione, collettivamente condivisa,
di un mondo in costante mutamento.
Ma come quindi “il tempo”, “lo spazio”, e “il modello”, (citando i paragrafi relativi agli aspetti teorici), entrano in gioco nell’architettura e cambiano, in rapporto alle trasformazioni culturali innescate dall’informatica? A guardar bene, da sempre, queste sono le categorie della ricerca speculativa delle teorie architettoniche. Tuttavia, qui, non appena si converrà con la definizione proposta dall’autore: “informazione, come applicazione di una convenzione a un dato”, acquisiscono come il senso di una “nuova sostanza”.E’ assolutamente convincente infatti, che al centro del progetto architettonico contemporaneo, gli architetti “creino il tempo e lo spazio”, e che il tempo appaia come “unico modo per descrivere uno spazio”, come anche lo spazio stesso, può essere considerato parafrasando un approccio cognitivo, un “contenitore di informazioni”, quindi vivente sulla base di applicazioni di sistemi convenzionali, che lo rendono definibile come assolutamente contestuale e legato alla fisiologia di chi lo vive.Del resto, la preoccupazione di delineare una possibile idea contemporanea di “modello”, non fa che precipitare le due nozioni precedenti, nel vivo dell’elaborazione informatica, che come si tende a sottolineare continuamente nel libro, non può, basata com’è sulle interconnessioni dinamiche di informazioni, non dar vita ad un modello simulativo, processuale, ma vedremo soprattutto interattivo.E fin qui, ci si troverebbe ancora nello schermo, nell’ambiente visivo generato dallo strumento, se non fosse per la presenza centrale degli altri due capitoli (Nuovi spazi dell’interattività, e Sintesi), che sottolinea in maniera forte, l’esigenza appunto di planare sul terreno dello spazio architettonico, di “reificare” il portato teorico della rivoluzione informatica. Infatti, “reificare”, verbo che appare molto caro a Saggio, costantemente preoccupato nella sua attività critica e didattica, di approdare all’architettura, non significa delineare e intravedere quegli esiti che l’autore sintetizza nella formula ”Architettura informatizzabile”, la quale coglie sicuramente l’estetica dell’indimenticabile Blur, l’edificio di qualche anno fa di Diller e Scofidio, realizzato per l’Expo svizzera del 2002? Quest’opera, fra le architetture citate nel libro, che come sostiene Saggio quasi fra le righe, c’è e non c’è, è accesa e spenta, on/off, cogliendone così quasi in due parole il senso; edificio costituito da una sorta di miriade di interruttori, non è forse il prototipo di quello spazio a portata di dita (e presto di sguardo), personalizzabile e amico dell’ambiente, reattivo e senziente circa la presenza dell’individuo? In questa luce apparirà chiara la metafora dello “spazio come contenitore di informazioni”, e investito sin dalla sua prima concezione dalle implicazioni del paradigma informatico. Eppure, questo libro, che lo ricordiamo, è appunto “Introduzione alla rivoluzione informatica in architettura”, oltre a sottolineare la necessità di un ripensamento della disciplina, proprio come era stata ripensata all’epoca della rivoluzione industriale, è ancora molto altro: infatti l’insieme dei temi, indagati attraverso un’esperienza più che decennale di critica e di docenza, condotta da anni su questo campo così peculiare, è chiaramente orientato alla pratica progettuale. Come non sentire in queste necessità e scoperte, quella Zeviana “critica operativa”, quell’atteggiamento si direbbe, rinunciatario alla rinuncia, di Zevi, sicuramente interprete altro, nel panorama italiano, che citando Baudrillard,- mancato da poco ci conviene aggiungere - poneva al centro del fare architettonico, la “crisi”, quale elemento in grado di “suscitare un’estetica di rottura” non appena un atteggiamento moderno l’avesse saputa trasformare in valore? E naturalmente è proprio questa definizione contemporanea e a-temporale di modernità, che viene a costituire la premessa su cui regge l’urgenza di questa trattazione.Certo la crisi, come si dirà in molti, parecchi anni dopo, può essere nominata anche conflittualità, rischio, squilibrio, e così via, ma senza quel “continua tu, tu, tu”, che l’autore continuando letteralmente Zevi quasi incide nel libro (non sfuggirà al lettore attento), sembra essere impossibile da trasformare in valore condiviso. In altre parole, non si suscita un’estetica di rottura senza lo sguardo molteplice delle “interconnessione dinamiche”, proprie del fare architettura ai tempi della rivoluzione informatica. Per Saggio dunque, se “tutto è pubblicato sul web” è urgente la necessità, quasi di portare il web, (quale mondo la cui navigabilità è quella del salto), considerato da un punto di vista cognitivo, direttamente nell’architettura: come a dire che possiamo raggiungere gli esiti di una Piazza Navona (risultato di una stratificazione collettiva nel tempo e nello spazio) attraverso l’intelligenza delle interconnessioni dinamiche su cui la rete sembra essere costituita.
E’ significativo che il nostro autore, sicuramente figlio di una
formazione culturale particolare (l’eredità della Tendenza che negli anni
settanta costituiva la premessa teorica di molte attività di ricerca nelle Facoltà
di Architettura Italiane, combinata in maniera imprevedibile con la vicinanza
dell’autore a Zevi, e la formazione americana alla Carnegie Mellon dove l’informatica
costituiva già materia di sperimentazione per molti architetti), avvii la
conclusione del libro, in “Architettura Informatizzabile” citando le parole di
Gilles Ivain, pubblicate nel 1958, nel primo numero dell’Internazionale
Situazionista, compendiando così, il ruolo, la prestazione, il senso
dell’Architettura Informatizzabile, che come ribadisce accoratamente Saggio, Ivain
profeticamente già intravedeva: la possibilità
di un’architettura in grado di “articolare il tempo”, “ modellare la realtà”,
nel senso di una “modulazione influenzale che si inscrive nella curva dei
desideri umani”.Infatti la richiesta di un’architettura nella quale sia la
dimensione collettiva, libera finalmente da pregiudizi, che quella individuale,
siano riformulate a partire dalla questione assolutamente centrale
dell’informazione, costituisce la misura esatta, per la quale lontani
dall’ideologia dei decenni passati, l’architettura contemporanea nel suo reificarsi,
sia in grado anche di soddisfare una certa sete di democrazia, spesso senza
risposta.Allora la “sostanza di cose sperate” che chiede quasi come
un manifesto, “un’architettura informatizzabile”, in grado di rispondere alle
molteplicità differenti della vita contemporanea, ai suoi fenomeni caotici
eppure fecondi, nonché alle sue contraddizioni, è quella dell’informazione
dunque, la quale attraverso il proprio sguardo molteplice, più che mirare al
consenso, diventa la premessa disponibile e necessaria, per suscitare risposte
moderne alla soggettività dei desideri umani da un lato, e alle crisi collettive
dall’altro, attraverso uno spazio necessariamente interattivo, formulato sul paradigma
di questa rivoluzione, di questo movimento armonico, senza il quale il sogno di
un’architettura davvero centrale nelle vicende umane, sembrerebbe impossibile.
Antonino Di Raimo |